S’intitola American Utopia ed è l’album più atteso dell’inverno, o quasi. Il “mezzobusto” non ne confezionava uno a suo nome dall’epoca di Grown Backwards (2004). Non che sia stato da allora con le mani in mano, anzi: collaborazioni musicali di vario genere (da St. Vincent a Fatboy Slim), allestimenti teatrali, libri ed eventi vari.
Ultimo in ordine cronologico, il progetto di condivisione Reasons To Be Cheerful, con relativi incontri pubblici (in Italia, lo scorso 26 gennaio alla Fondazione Prada di Milano). Proprio questa ricerca di “motivi di contentezza” è stata fonte d’ispirazione per il disco dedicato all’Utopia Americana.

Non si tratta ovviamente di un’apologia dell’ottimismo: come potrebbe, con i tempi che corrono. Semmai di uno sguardo panoramico sullo Stato dell’Unione, tentando di capire perché sullo slancio delle aspirazioni originarie si sia arrivati sull’orlo del baratro.
Programmaticamente, però, Byrne si dichiara refrattario alla disperazione e al cinismo, nonostante Trump (al cui indirizzo ha postato una playlist intitolata eloquentemente The Beautiful Shitholes, dopo la sua piazzata sui “paesi di merda”), nella convinzione che “le canzoni aiutano”.

Sarà così? All’ascolto, dovendo essere schietti, l’album non è memorabile. Eppure le premesse erano rassicuranti, a cominciare dal rango dei complici: vecchi (Brian Eno, responsabile delle musiche in otto casi su dieci e implicato nelle registrazioni in quattro) e nuovi (Sampha e soprattutto Daniel Lopatin, alias Oneohtrix Point Never, che partecipa a cinque pezzi e ne firma un paio).
Vi sono guizzi di classe purissima: il break al gusto dub (con tanto di melodica) che interrompe l’andamento sereno di “Gasoline And Dirty Sheets”, l’alato sbocco corale di “Dog’s Mind”, l’impertinente fischiettare sul ciondolio tropicale di “It’s Not Dark Up Here”, la melodia in assenza di gravità – contrappuntata dagli archi – di “Doing The Right Thing”.

St. Vincent e David Byrne Photo by Andrea Sartorati – CC BY 2.0
Se poi uno cerca groove funky, voce nevrotica e squillare di fiati (nostalgia canaglia!), troverà conforto in “Everybody’s Coming To My House”. Il meglio sta comunque nei testi, alla fin fine. Istantanee del mondo in cui viviamo. “Dance Like This”, niente affatto “dance”, sembra un ritratto dei millennials: “Una mamma carta di credito, un papà invisibile, opportunità di carriera, che non hai mai avuto”.
Affiora qui e là Internet: “Dicono che la risposta sia distante un clic” (“Gasoline And Dirty Sheets”) o “Il mio software è famoso ovunque” (“Every Day is A Miracle”, altrimenti consacrata a bizzarre visioni non antropocentriche: “Uno scarafaggio può mangiarsi Monna Lisa, il Papa non significa un cazzo per un cane, e gli elefanti non leggono i quotidiani”).
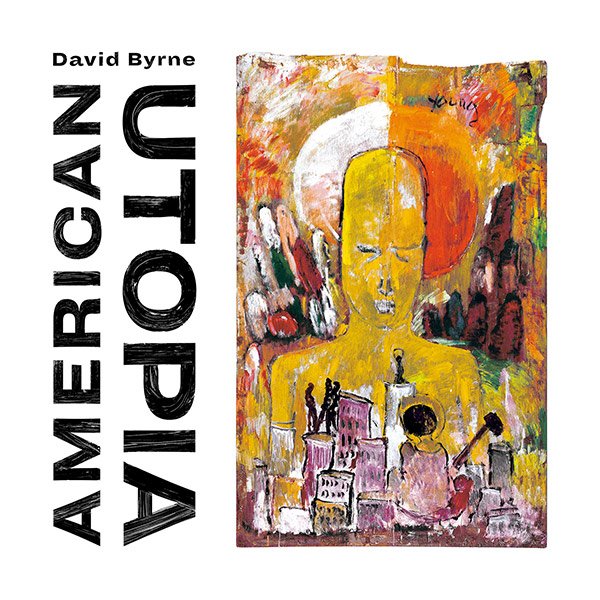
Su tutto, la condizione umana: tra sfigati (“Ti tocca cantare per svoltare cena”) e bon vivant (“Lei e io visitiamo i santuari del turismo, siamo fieri della nostra automobile, lei sceglie alcuni manufatti, io sono appassionato di cucina locale”). A proposito di gitanti: “Siamo solo turisti in questa vita, turisti e basta, ma la vista è gradevole”.
Da rimanerne affascinati, ma il batticuore è un’altra cosa (avete presente Youth del suo amico Sorrentino? Ecco…). Ne ammiriamo l’intelligenza superiore, c’inchiniamo di fronte a essa e attendiamo con immutata fiducia i prossimi concerti “coreografati”: “Il mio show più ambizioso da quelli filmati per Stop Making Sense“.
Alberto Campo
La recensione è pubblicata sul Mucchio n.764 in edicola nel mese di marzo 2018.

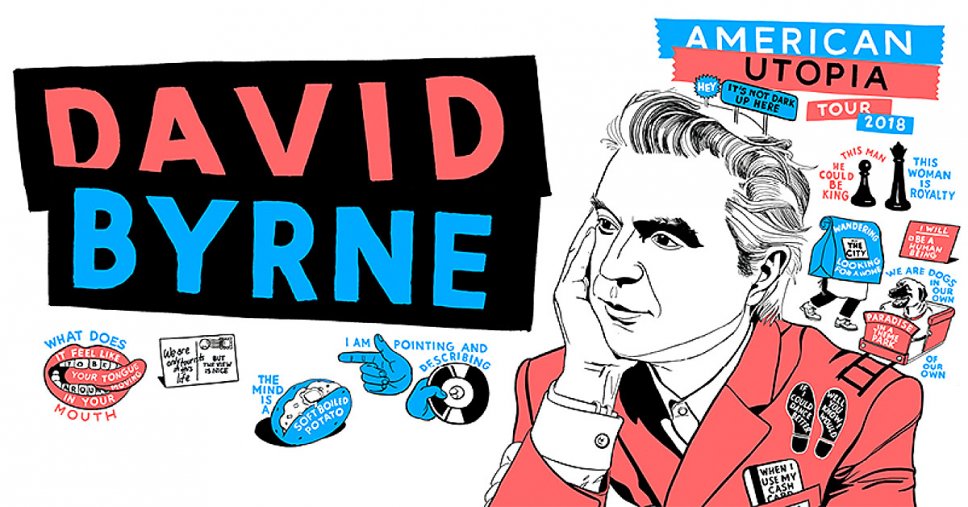


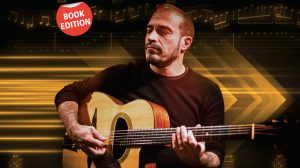





Aggiungi Commento